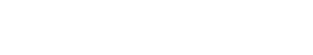PEDIGREE
Pedigree è la storia di un giovane uomo, della sua famiglia con due madri, del padre donatore e dei suoi cinque fratelli di sperma sparsi per il mondo.
Pedigree racconta le difficoltà di una nuova generazione alle prese con genitori biologici e genitori di fatto, con nuove problematiche di identità e di coscienza.
Pedigree riflette sulle prospettive di determinate scelte, dei diritti, dei desideri, delle aspettative di una generazione in provetta alla ricerca di nuove radici e alle prese con nuove paure.
Un lavoro che è allo stesso tempo un pugno allo stomaco e una carezza, dotato di una scrittura che scivola leggera ma si attorciglia alle budella, carico di umanità.
CREDITI
di Babilonia Teatri
regia Babilonia Teatri
con Enrico Castellani
e con Luca Scotton
parole Enrico Castellani
cura Valeria Raimondi
luci e audio Babilonia Teatri/Luca Scotton
direzione di scena Luca Scotton
un progetto di Babilonia Teatri
produzione Babilonia Teatri, La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale
co-produzione Festival delle Colline Torinesi
organizzazione Alice Castellani
scene Babilonia Teatri
costumi Franca Piccoli
foto di scena Eleonora Cavallo
Video promo

“Quello che sempre ho apprezzato nelle opere di Babilonia Teatri è la potenza delle immagini che sono capaci di evocare, come il ballo in controluce con i due vestite da sposa delle mamme. Si stagliano nel quadro della scena con un’evidenza che non necessità parola. Intagliano la retina e si stampano nella memoria.”
RASSEGNA STAMPA
L’a solo di Enrico Castellani, autore del testo di Pedigree, lavoro di Babilonia Teatri con Valeria Raimondi curartrice, atto d’accusa inesorabile di un figlio biologico che pure ama le sue due madri, e che rifiuta la figura del donatore di sperma di cui è erede, è una presa di posizione vitrea, impressionante, anaffettiva e micidiale di un uomo che spara a zero da un trono formato da due posteriori di moto Harley-Davidson. Uno sfogo che supera in virulenza un monologo di anni fa solo un po’ apparentabile, A number di Caryl Churchill. E qui Castellani ha un’acidità, una forza di iterazione ed elencazione (i fratelli nati dai gesti di quel padre solitario sono sei, sparsi nel mondo) soltanto ammorbidita da brani di Elvis Presley. Un copione senza pietà sul futuro artificiale.
…La sfida che affronta Enrico Castellani in Pedegree, per esempio, è misurare la capacità di un giovane uomo di chiarire a se stesso e agli altri il concetto di identità. Questione non da poco per uno che ha due madri, un padre donatore e cinque fratelli di sperma sparsi per il mondo e tutti con lo stesso identico nome: Loris. Lo spettacolo parte dal mito delle due metà descritto nel Simposio di Platone e narrato da Aristofane: un tempo gli uomini erano perfetti ma Zeus invidioso li divise a metà e da allora ciascuno è in cerca della propria anima gemella. Qui le due metà sono dei polli…uno, due, tre, quattro, cinque. Castellani, seduto su un divano rosso, li tira fuori dalla borsa per cucinarli allo spiedo. L’odore pervaderà la sala, ma sappiatelo, non finirà con cosce croccanti distribuite al pubblico.
Nel mezzo, Pedegreee parla di scelte e di diritti, di desideri e di generazioni in provetta con una scrittura asciutta e ironica, imperfetta nella costruzione drammaturgica ma di impatto, come sono spesso gli spettacoli di Babilonia Teatri.
Sono in sei, e si ritrovano ogni anno per il pranzo di Natale: Lui, Chang, Ben, Conchita, François e Jack. Festeggiano insieme il Natale ogni anno a casa di uno di loro. L’anno scorso a Pechino da Chang, due anni fa a New York da Jack, tre anni fa a Sydney da Ben, quattro anni fa a Parigi da François, cinque anni fa a Madrid da Conchita e quest’anno a Roma, per l’appunto da Lui.
Ma – come avrete capito dai loro nomi e luoghi di residenza – quelli che compongono il gruppo di fratelli messo in campo da «Pedigree», il testo di Enrico Castellani presentato da Babilonia Teatri nell’ambito della XVIII edizione della rassegna «Primavera dei Teatri», sono fratelli particolari: nel senso che si tratta di fratelli biologici, nati da madri diverse e da un solo padre, un anonimo donatore di sperma. In breve, costituiscono sei rappresentanti esemplari della «generazione della provetta».
Quale sia la loro condizione l’esprime giusto Lui, il narratore, quando – rivolgendosi al padre che non conosce – gli dice: «Tu per me sei sempre stato una parola su cui tirare un segno, una parola da cancellare e da sostituire con un’altra. Ogni volta che mi trovavo davanti la scritta mamma e papà tiravo una linea e correggevo mamma e mamma».
Infatti, Lui ha due mamme, mamma Marta e mamma Perla, e nessun padre: nessun padre riconoscibile fisicamente e, invece, un padre che si riduce a quell’aggettivo, biologico, ad un tempo evanescente ed opprimente. E dunque, è l’ossimoro indotto da una scissione dell’anima e della dualità genitore/genitrice codificata dalla società ciò che assume come leitmotiv il testo di Castellani. Di qui il fatto che Lui dichiari: «Io non sono un essere binario» e che specifichi: «Io voglio i forse i ma le opinioni divergenti le minoranze le sfumature le intonazioni le differenze i colori», concludendo: «Per me non esistono solo bianco o nero vero o falso bene o male pro o contro».
Siamo di fronte, poi, a un ossimoro che diventa insieme drammatico e tenerissimo allorché, sempre rivolgendosi al suo padre ignoto, Lui prima gli dice: «Lascia che io abbracci quel corpo da cui sono partito, vorrei conoscerne l’odore e il calore, conoscerne il suono ed il rumore» e subito dopo implora: «ma non scoprirmi gli occhi, lascia che io non veda, lascia che io viva ignorando la tua figura». «Riflettermi nei tuoi occhi mi fa paura», riassume Lui. Perché Lui possiede solo le parole in quanto segni grafici: a partire dal «pedigree» che hanno visionato le sue due mamme a pagina 28 del book dell’ospedale. E invece ha bisogno – il Lui che si sente come un alieno dei film di fantascienza, di quelli in cui «le astronavi volavano su cieli di cartone», e aspetta «che il cartone marcisca e si decomponga», «che sparisca» e che gli «lasci vedere il cielo e le stelle» – di «nomi per chiamare le cose».
Insomma, il testo oscilla fra l’analisi gelida di una situazione ormai ricorrente nel nostro mondo lacerato e la dolcezza di un anelito all’innocenza di sentimenti antichi: un anelito che poi, molto più in profondità, consiste nella spinta verso una ritrovata fraternità, verso la riconquista dell’età dell’oro in cui, appunto, dalla «provetta» dell’individualità esistenziale e intellettuale si spargeva non il seme onanistico dell’anonimato, ma la forza vitale di pensieri che s’incarnavano in parole capaci, giusto, di chiamare e, quindi, di far esistere le cose.
Ebbene, l’allestimento di «Pedigree», curato da Valeria Raimondi, gira intorno a due oggetti di scena che, affiancati, traducono perfettamente tutto quanto ho fin qui osservato: a sinistra un girarrosto elettrico e a destra una poltrona con i fianchi e i braccioli sostituiti da ruote posteriori di moto, parafanghi, fanali e tasche laterali. E da una di queste tasche l’interprete tira fuori dei polli (se ne parla nel testo, a proposito del pranzo natalizio dei sei fratelli), li infilza sullo spiedo e li mette a cuocere nel girarrosto per la durata esatta dello spettacolo.
In breve, vengono accoppiati, simbolicamente, il dato realistico in sé concluso (un singolo oggetto, che svolge davvero la funzione per cui è stato creato) e il dato psicologico in divenire (un oggetto che risulta da più oggetti, sì da configurare la parcellizzazione e, perciò, la frantumazione del dato realistico).
Tanto suggerisce, ad esempio, l’intensa e bellissima sequenza che, accompagnata dalla «(I can’t help) Falling in love with you» di Elvis Presley, vede l’interprete che appende sulle grucce i due vestiti bianchi delle sue due mamme, li bacia, li accarezza e li lancia in una danza gioiosa e immemore nel cielo del desiderio impossibile che uno dei due sia l’immagine del padre. E infatti, i due vestiti saranno poi chiusi in buste di plastica da cui verrà completamente aspirata l’aria: siamo di fronte alla «conservazione» della Madre e, di pari passo, alla sua «messa fra parentesi», in attesa delPadre.
Ma, per il momento, quella realtà, la realtà della Madre, è la sola che gli è data: sicché l’interprete, a un certo punto, diventa lui stesso la Madre, simulando la gravidanza con l’applicarsi sul ventre, sotto le mutande tirate su dai pantaloni, la gran tetta di plastica che prima, calando dall’alto, s’era offerta ai suoi baci. E finisce come non poteva non finire, con Lui (lo stesso Enrico Castellani, bravissimo) che, inverando il testo fino all’iperrealismo, si mangia tranquillamente una coscia di pollo ormai cotta a puntino.
Accarezzano lo spettacolo, come con una ninnananna che oggi si definirebbe post-moderna, anche il Presley che all’inizio canta «Love me tender» e alla fine «White Christmas», imitato dietro un microfono dal direttore di scena Luca Scotton. Mentre tocca al reuccio Claudio Villa la fatidica «Mamma». E insomma, per giunta sul filo di una sottile ironia, Babilonia Teatri colpisce ancora nel segno, con una proposta lucida e tagliente che ci chiama in causa circa uno dei più scottanti problemi della nostra vita complicata.
Lo spettacolo affronta la questione della genitorialità possibile, possibile altrimenti, attraverso le parole di un figlio e delle sue due madri, nato biologicamente da un padre donatore e da quello che ne consegue sul piano dell’identità, dello stigma collettivo, della necessaria quanto mai risolta questione di una nuova semantica familiare forse auspicata, forse necessaria ma ancora di là da venire. Ecco allora che sul piano della riflessività sociologica, alla quale il teatro di Babilonia non smette mai di rimandare, lo spettacolo non può che essere quello della contingenza della tarda modernità. Lo spettacolo incarna questa contingenza, la connota come parola problema e la esprime già in quello che fa dire al suo protagonista – Enrico Castellani, sempre credibile in scena – quando afferma “Io non sono un essere binario”. Eppure riconoscere questo stato non basta e gli strumenti che abbiamo per raccapezzarci nella complessità sono per forza quelli della banalità, cioè del piano di discorso popolare – il pop di Babilonia – che è più mediale che filosofico, più di senso comune che aulico, più basso che alto. E non può che essere così. Se è vero che l’arte è un modo per comunicare osservazioni, quello che ci restituisce Babilonia è l’osservazione di una impossibilità di dare risposte definitive. Binarie appunto.
E lo spettacolo è costruito drammaturgicamente per portare qui. Le azioni e i capitoli di testo che imbastiscono il racconto, nella lingua serrata che abbiamo imparato a conoscere, tracciano una specie di cerchio che parte dal gesto performativo di cuocere quattro polli in un girarrosto elettrico e di cui sentiamo progressivamente l’odore. Una chiave immersiva che attiva i corpi e il simbolico perché quei 4 polli sono l’innesco del racconto del protagonista-Enrico bambino e del compagno di scuola Denis che gli rivolge la cruciale domanda sul perché lui non abbia un babbo ma due mamme mentre cercano di risolvere un problema di matematica in cui c’è da fare di conto su quanto pollo si mangi in una famiglia che ha comprato 4 polli ed è composta di 6 figli più un padre e una madre. Quel Denis che, inconsapevolmente, è l’espressione dello stigma sociale, che mette in crisi il nucleo formato dal figlio e dalle sue madri, di un padre che non servirebbe perché il “biologico” è un incubo e un paradosso di oggi: la natura e la sua ridefinizione sempre più artificiale, quella degli hamburger di seitan ad esempio.
Nella traccia sonora delle canzoni di Elvis, già di suo macho travestito, o di “Mamma” di Beniamino Giglio – e della danza del figlio con le sue mamme, nell’abbraccio con i loro vestiti bianchi sottovuoto – si struttura questo racconto, la riflessione arrabbiata, il dubbio, la ricerca di questo padre biologico. C’è poi la decisione di diventare donatore a sua volta ma scegliendo, a differenza del donatore delle sue madri, di non voler essere contattato dal possibile figlio al compimento del diciottesimo anno d’età. Interrompendo così una inevitabile relazione fra riproduzione della specie ed eredità genitoriale, dissolvendo il pedigree; e allo stesso tempo lasciare correre così il rischio che si vorrebbe evitare, come quello di scoparsi la propria sorella. Non c’è scelta giusta, certa, da contrapporre all’errore: solo il tentativo di vivere la contingenza.
Ma c’è anche il bisogno di un ricongiungimento, una specie di nemesi finale, nel pranzo di Natale con i propri fratelli biologici che provengono da diverse parti del mondo e con i quali dividere quei polli. Polli da cui si parte e a cui si torna, con buona pace di Denis e delle risposte che comunque, forse, non è così importante avere.
Eccezione veneta (e non sarà la sola) è Pedigree di Babilonia Teatri. Consueto stile chirurgico per un testo su un figlio con due madri e un padre biologico che non fa parte della famiglia. Enrico Castellani e Valeria Raimondi (quest’ultima non in scena) pongono l’accento su una questione con la Q maiuscola: la famiglia. Che cosa è una famiglia, quante gradazioni di parentela possono esistere, come si sente un figlio con genitori dello stesso sesso e che deve la vita agli spermatozoi di un uomo che rimane sconosciuto almeno fino alla maggiore età. Super temi. Ai Babilonia il merito di affrontarli.
Con un padre donatore di sperma “si corre il rischio di scoparsi la sorella senza saperlo”. Possibile ma non probabile. Sembrerebbe un modo laico di porre il problema ma il mordente è sensibilmente ammorbidito. Dalla musica tender di Elvis e dai leggeri abiti bianchi delle due mamme.
In Pedigree, i veronesi Babilonia Teatri – con lo stile scandito e asciutto, graffiante e pop che li contraddistingue– affrontano di petto non solo il tema del “gender”, ma anche la per molti spinosa questione della inseminazione eterologa. Mentre si cuociono dei polli arrosto, come in un celebre spettacolo di Rodrigo Garcia di molti anni fa, un uomo racconta di sé e delle sue due mamme in un discorso che chiama in causa direttamente il fantomatico padre donatore. È un esame di coscienza, privata e collettiva, una narrazione interpretata con caustica aderenza da Enrico Castellani, solo in scena (mentre il tecnico Luca Scotton è, come sempre, testimone meta-reale del dispositivo teatrale) su musiche della tradizione rock.
C’è un amore per la P, la lettera, nei titoli del gruppo veronese, Leone d’argento ’16 alla Biennale di Venezia, Babilonia Teatri. Si parte da “Popstar”, passando per “Pinocchio”, “Purgatorio” e arrivando a quest’ultimo nato “Pedigree”. Che la P è anche l’iniziale di Padre che è centrale nel loro discorso scenico dove è proprio l’assenza del genitore maschio a farsi presenza ingombrante fino ad essere ossessione, tarlo, domanda strisciante che riempie le giornate e i pensieri di una vita. Un ragazzo ormai uomo (ritorna la forza espressiva di Enrico Castellani, vigoroso senza essere tragico) va a ritroso, indietro a scoprire i perché di quel buco nero che lo cinge e stringe. Cresciuto, e molto amato, da due madri, ha sempre sentito un vuoto incolmabile. Il padre biologico ha donato il suo sperma in una banca del seme per l’egoismo delle due donne che l’hanno sì ben cresciuto ma anche privato della sfera maschile utile, necessaria, fondamentale. L’indagine, scandita dalle musiche sdolcinate e ammiccanti, sensuali e pelviche (il gesto della penetrazione che manca a due donne), di Elvis, fa capolino sulla famiglia e sulla discriminazione paesana, sui giudizi provinciali sulle coppie di fatto.
Ma non è qui, comunque la si pensi, che i Babilonia si soffermano. Il salto è andare indietro, a quella mancanza paterna di questo genitore-milite ignoto, fumoso e allo stesso tempo onnipresente. Perché, indubbiamente, anche se il genitore mancante non ha potuto influire sull’educazione e sull’atteggiamento, sul DNA e sui tratti fisici quello sì. Quella del ragazzo è una “vendetta” lontana e distante: ogni anno per Natale organizza una cena, irreale, che riempie d’attesa tutti gli altri giorni dell’anno, con gli altri “figli” biologici dello stesso padre sparsi per il globo. Ed è questo senso della famiglia che forse lo lega maggiormente rispetto al rapporto con le due donne. Il sangue, seppur inspiegabile, pulsa più dell’affetto, per quanto grande sia. E sempre per vendetta diventa a sua volta donatore, mettendosi nella stessa condizione del padre. Il padre (ma anche la madre in caso di due uomini che allevano figli), come figura simbolica, è necessaria, non solo a livello biologico; non si può estrapolare e censurare, cancellare e nascondere la sua presenza terrena, materiale, costante. Padre e madre non possono chiamarsi semplicemente “genitore 1” e “genitore 2”. Con buona pace dei vendoliani.
In principio era il mito, quello di Aristofane nel Simposio, laddove si racconta di un’umanità fatta di esseri a coppia, senza distinzione di sesso, con quattro braccia, quattro gambe e due teste. La loro potenza impaurì Zeus che decise di dividerli per poterli meglio controllare e da allora ogni metà è alla ricerca di quella mancante sempre senza distinzione di sesso. Questo il punto di partenza di Pedigree di Babilonia Teatri. Eppure mi sbaglio: il punto di partenza è un’immagine. Enrico Castellani, seduto su una poltrona sidecar, infila polli in uno spiedo. Quattro polli. Poi li mette a cucinare mentre Elvis canta Love me tender. I quattro polli sono l’immagine e la cifra di questo spettacolo conturbante.
Pedigree è un J’accuse lanciato senza remore o paure contro Denis, il bambino che chiede, nel passato dell’infanzia, mentre si risolve il compito estivo di dividere quattro polli tra mamma, papà, e i suoi cinque fratelli: ma perché tu non hai un papà? Si perché l’altro bambino, ha due mamme. Nato da una donazione di sperma, figlio di due mamme, colui che parla e accusa non comprende alcuna visione manichea che divida, come Zeus, tutto a metà. E così cerca i fratelli in vitro, sparsi per il mondo, di questo padre assente per festeggiare le feste. Con i suoi cinque fratelli e le due mamme, divide al pranzo di Natale quattro polli in otto parti uguali. I polli alla fine sono cucinati e Enrico Castellani se li mangia in scena mentre Elvis canta e Luca Scotton si fa sua controfigura in playback.
I polli allo spiedo, arrostiti in scena, con la loro presenza fisica, il loro odore che per la vastità dello spazio e l’aria condizionata si sente appena, almeno nelle prime file, ma sufficiente per sentirne un poco il segno, loro sono immagine potente che si fa processo di un pensiero in atto. Quello che sempre ho apprezzato nelle opere di Babilonia Teatri è la potenza delle immagini che sono capaci di evocare, come il ballo in controluce con i due vestite da sposa delle mamme. Si stagliano nel quadro della scena con un’evidenza che non necessità parola. Intagliano la retina e si stampano nella memoria.
Quello con cui riesco meno a fare i patti è la modalità oratoria del loro teatro. Babilonia Teatri dice come la pensa, chiaramente, e lo dice senza pause, con un incedere che non ammette passi indietro, in maniera feroce quasi senza respiro, come bersaglieri in corsa. Le parole sono gettate come pietre al di là del palco. E obbligano a prendere posizioni, a non rimanere inerti. Scuotono e colpiscono senza paura di far male. Sono atto politico puro. In un mondo imbambolato nella modalità politically correct, è modalità coraggiosa, non da ignavi, ma da uomini e donne che si prendono la responsabilità del proprio dire. Ho un grande rispetto e ammirazione per questo coraggio di dire. La mia fatica, e lo dico con rammarico, è che non riesco a convincermi che il teatro in senso ampio abbia nelle sue corde questa funzione. O meglio: l’atto scenico, in quanto pubblico, è sempre un atto politico, ma credo che tale atto si manifesti con maggior potenza quando la sua azione metta in rilievo quello che Thomas Mann chiamava lo sguardo stereoscopico, che metta in luce le contraddizioni dell’essere nella compresenza di punti di vista opposti. Ma non solo: credo in una modalità che investa più i processi che coinvolgono il pubblico, l’uso dell’immagine in movimento, i mezzi scenici nel loro complesso.
Babilonia Teatri scinde le due cose: immagine potente che si staglia con l’evidenza di un fulmine sulla retina, parola martellante che colpisce le orecchie e l’anima come un maglio in cui è assolutamente evidente il loro punto di vista. Questa divisione, sì manichea, che avevo già notato in Jesus, mi lascia perplesso, benché ne comprenda l’efficacia e la potenza. Parola e immagine condividono lo spazio scenico ma si toccano raramente, e nel caso di Pedigree mai del tutto. È senz’altro una modalità originale, potente. Anche Conde di Torrefiel scinde la parola dall’immagine. Essa è sempre sovrapposta dall’esterno all’immagine muta, ma la parola ha sempre un che di dubitativo, è lasciato sospesa all’immagine come domanda senza risposta. Parola e immagine sono adiacenti, si affiancano in contrappunto. In Babilonia Teatri sono come due linee melodiche che procedono indipendenti, prima una e poi l’altra, in un incedere a numeri chiusi assolutamente tradizionale. Certo tale tradizione viene scardinata dall’interno dalle modalità estremamente aggressive del dire e nella costruzione dell’immagine. È un teatro che abita la battaglia e non si tira indietro mai.
Al di là delle perplessità che stanno nella sfera del gusto personale, i lavori di Babilonia Teatri hanno un’indubbia potenza, e hanno il pregio indiscusso di non passare inosservati. Sono talmente potenti da mettere in discussione le convinzioni che abbiamo prima di entrare in scena. Siamo costretti a rivederle, a rifletterci sopra. E un risultato di non poco conto che merita un applauso a scena aperta.
«Questa è la mia accusa verso chi non considera la diversità come una possibilità». Un’accusa posata e diretta, come lo sguardo verso la platea di Enrico Castellani in Pedigree, feroce come sanno esserlo i bambini, senza filtri dunque, ma anche senza mediazione. Il mondo a cui rivolgersi è quello della “norma” che permea finanche i testi di matematica per cui la famiglia è composta da «un papà, una mamma, cinque fratelli e quattro polli da dividere equamente». Ma la Storia, e prima di essa il Mito (quello degli ermafroditi, raccontato da Aristofane nel Simposio di Platone: due anime in un solo corpo, senza distinzione di sesso), ci racconta che quella è soltanto una delle variabili, non l’unica.
Un giovane uomo ripercorre la propria vita; ricostruisce, narrandolo, il proprio universo, le prime esperienze sensoriali fatte di «voci, odori, affetti, come quelli degli altri, niente di strano», si sofferma su alcuni episodi, come quello, significativo, in cui il compagno di classe, alla vista del problema di aritmetica, sposta l’accento dalla sua risoluzione all’evidenza della diversità dell’amico: l’esser figlio di una coppia omogenitoriale, una famiglia in cui lui, mamma Perla e mamma Marta non avrebbero potuto dividere equamente i polli. Due figure benevole queste: materne, candide, evocate dai due abiti bianchi da far dondolare al soffitto, con i quali giocare, inscenare una danza dei ricordi che si muove sulle canzoni di Elvis, che caratterizzano tutto lo spettacolo. Can’t help falling in love with you, si sente, non posso evitare di innamorarmi, perché il problema non è convivere con la diversità, ma il diritto all’esistenza del diverso.
Su questo si concentra quest’ultimo lavoro di Babilonia teatri visto in anteprima nazionale a Primavera dei teatri e che proprio in questi giorni viene presentato al Festival delle Colline Torinesi. Il titolo è, racconta Castellani, «una provocazione che è andata a bussare alla finestra» (e una prima lettura l’avevamo vista su invito di Rodolfo di Giammarco allo scorso Garofano Verde), con la quale sottolineare la distanza tra la storia genealogica – determinata appunto attraverso il certificato – e la storia affettiva, nella quale genitore non è chi ha dato soltanto il proprio contributo genetico. Ventitré cromosomi e il consenso alla conoscenza una volta raggiunta la maggiore età non fanno di quell’uomo (forse rappresentato nella figura volutamente marginale di Luca Scotton in scena) un padre. Su questo intrecciarsi fluido di eventi, una presenza sempre più ingombrante, che progressivamente ci raggiunge dal palco della Sala Consiliare, entra nelle nostre narici, si adagia sui nostri vestiti, è un odore intenso che ci distrae appena quell’attimo necessario a capire che non si tratta affatto di distrazione. In apertura, Castellani, seduto su una poltrona ricavata da un sidecar Harley-Davidson (nero e marchiato a fuoco, dell’ebbrezza e del senso di libertà che si porta dietro la famosa casa motociclistica), prende, ancora prima di iniziare a parlare, quattro polli: li bacia, con fare quasi rituale li infilza su uno spiedo e li mette a rosolare. Non sappiamo ancora il nesso, ma il teatro suo e di Valeria Raimondi (che qui come sempre cura la regia) ci ha abituato a considerare l’indispensabilità del segno performativo rispetto a quanto accade in scena. Quei polli allo spiedo ritornano certo nelle parole, ma nel corso dei cinquanta minuti – di spettacolo e di cottura – con la loro presenza materica che colpisce olfatto e gusto, acquisiscono il peso della condivisione del disagio del protagonista. Proprio quell’odore a tratti nauseante rimarca un senso prima di tutto fisico, quindi concettuale. Allora la parola teatrale e popolare di Babilonia Teatri, che come dichiarano nel loro manifesto poetico può esistere soltanto «se può ancora essere specchio della società in cui vive», non ha più bisogno nemmeno di essere sputata in faccia con violenza. Forse, in distacco da quella sonorità che li ha caratterizzati, la parola può essere anche dolce, cristallina, cullata, sempre mantenuta su un piano addirittura colloquiale, senza per questo smettere di avere su di sé la forza di un pugno nello stomaco.
Un tempo esistevano solo ermafroditi. Erano esseri con quattro gambe, quattro braccia e due teste. Poi vennero divisi e da ognuno di essi si generarono due donne, due uomini, oppure un uomo e una donna. Da allora quelle due parti cercano a loro metà perduta.
Così vuole il mito, e così racconta la realtà portata in scena da Babilonia Teatri in Pedigree, ultimo spettacolo della compagnia veneta Leone d’Argento alla scorsa Biennale di Venezia, presentato in anteprima a Castrovillari per Primavera dei Teatri. Il festival torna così su nuove drammaturgie che trovano il coraggio di affrontare di petto temi di attualità: tra questi, le crisi di identità e di coscienza di figli di coppie omosessuali, tra uteri in affitto e banche del seme. L’anno scorso i genitori erano Luca e Tony, i Geppetto e Geppetto di Tindaro Granata. Quest’anno sono Marta e Perla, mamma e mamma raccontate in scena da Enrico Castellani. Il linguaggio è quello pop che la compagnia veneta ci ha abituato a conoscere: la scrittura schietta e scandita, la recitazione piatta e in apparenza distaccata.
Seduto su una poltrona sidecar fiammante, Castellani dà inizio a una lunga lettera di un figlio al padre “in provetta” inforcando quattro polli su uno spiedo: di fianco a lui un girarrosto elettrico li cuocerà pian piano, emanando un odore di carne bruciata sempre più forte nei cinquanta minuti di spettacolo. D’altra parte a mettere in crisi Castellani-bambino era stato proprio un problema aritmetico legato alla divisione dei polli: come dividerli in parti uguali in una famiglia composta da membri pari? E come dividerli senza un papà?
Marta e Perla sono due abiti bianchi che danzano appesi a due grucce, segni visibili della loro presenza-assenza: Castellani le allontana, le avvicina, le fa volare in aria, le mette infine sotto vuoto nei sacchetti aspira-tutto per risparmiare spazio nel cambio stagione.
Sulle note delle canzoni d’amore di Elvis, da Love me tender a Can’t help falling in love, prendono corpo le incertezze e le aspettative di una generazione “in provetta”: sono le domande sul perché di una scelta, sul proprio riconoscimento in una collettività in cui non ci si vuole sentire “bizzarri”, sul rapporto con una parola – “padre” – da cancellare. Perché il consenso a far conoscere, alla maggiore età del figlio, il proprio nome, non basta a rendere chi ha donato il seme un padre: tutt’al più può portare a creare un gruppo di sconosciuti fratelli sparsi per il mondo – “i frutti del seme di Paul” – connessi via chat che si ritrovano per il Natale.
Le domande poste dal palco toccano diversi punti attorno al tema: il rapporto tra genitori biologici e di fatto, la distanza tra l’identità genetica scritta nel “pedigree” e quella che deriva dalla continuità degli affetti. Niente, forse, che non sapessimo già, o almeno così ci sembra alla fine dello spettacolo. Tuttavia questi interrogativi hanno il merito di porre lo sguardo su questioni che, per quanto possano apparire assodate, restano oggetto di polemica nella superficialità (per nulla scontata) delle cronache quotidiane. Le domande prendono corpo nella crudezza delle parole e nei pochi elementi simbolici che segnano la scena. Tra questi, la presenza di una figura maschile ai margini del palco, rappresentata come di consueto da Luca Scotton alla direzione tecnica, che prenderà il centro della scena solo per una canzone cantata in playback. E, non ultimo, l’odore della carne che gira sugli spiedi. A cottura ultimata, è tempo di mangiarli, i polli: meglio se a morsi, senza tanti problemi di divisione in parti pari.
Una volta c’era Edipo, con due padri e una gobba. Ormai però ce ne è venuto a noia.
Sarà forse un caso che sia Ovidio, sia Kafka abbiano scritto delle “Metamorfosi”? Proprio in quelle pagine il Nasone di Sulmona ha citato il mito platonico dell’androgino, della mela perfetta: avrebbe forse dato ai polli arrosto della personalissima “Lettera al padre” di Babilonia Teatri un tocco “gourmand”…
Ciò che invece sappiamo per certo è che questo Edipo in provetta può contare su due madri sollecite e amorevoli, mamma Marta e mamma Perla.
Enrico Castellani, seduto fieramente sulla sua fiammante poltrona-sidecar, infilza l’uno dopo l’altro quattro polletti. Sistema poi il lungo spiedo d’acciaio all’interno di un girarrosto verticale.
Saranno l’inconfondibile profumo e la loro lenta doratura a scandire il tempo-ritmo dell’azione.
Sul palco del Festival delle Colline Torinesi, trasformatosi per l’occasione in scatola buia «a metà strada tra una galleria d’arte e un locale di street food», oltre a Castellani compare il fidato Luca Scotton, anche stavolta in veste di addetto alle funi e controfigura.
Saggiamente antifrastiche sono poi le scelte musicali, dal “Love me tender” del playboy Elvis all’inno alla “Mamma” del “casanova” Claudio Villa. A suggellare questa incursione negli anni Cinquanta, un microfono vintage, che accompagna l’epistola a voce alta di “Pedigree”, ultima fatica della compagnia veneta.
Giocando con cromie e tonalità dissonanti Babilonia Teatri cerca di proporre un continuo “controcanto” tra vicenda e accompagnamento, tra mythos e luoghi comuni da sfatare. Tutto ciò servendosi di espedienti scenici a tratti elementari ma di sicura presa sul pubblico: stilizzati fino al limite dello stereotipo sono le due figure materne, che diventano una coppia di lunghi abiti bianchi posti su gruccia. Castellani lancia le sue mamme, le rincorre e le abbraccia, per riporle infine in due sacchetti sottovuoto, privandole dell’ossigeno.
Al di là della selva di metafore più o meno esplicite che va dischiudendo, questo nuovo lavoro si conferma intenso e “sapido”, riuscendo a raggiungere la meta cui ogni spettacolo teatrale dovrebbe approssimarsi: per dirla con Attisani, «il bisogno [per gli spettatori] di essere sorpresi e autorevolmente messi in discussione».
È una rivendicazione di vita, di esistenza, di identità questo “Pedigree”, contro tutti i vincoli dello schematismo “binario”. Casus belli è il semplice quesito di aritmetica proposto da un libro delle vacanze ormai sepolto nella memoria individuale, ma mai veramente rimosso: una famiglia di otto membri – padre, madre e cinque figli – deve dividere quattro polli in parti uguali. A quanto equivale ciascuna porzione?
Il puerile indovinello fa scattare subito una domanda ben più corrosiva: Denis, compagno di classe del protagonista, chiede infatti all’amichetto per quale ragione non abbia un papà. La replica, in pieno stile “terza legge di Newton”, non tarda ad arrivare: “E tu, perché hai una mamma sola?”.
L’interrogativo divorerà nel tempo l’animo del nostro personaggio (possiamo chiamarlo Kafka?) come un tarlo. Il ragazzo, pur cresciuto nell’affetto da una splendida coppia omogenitoriale, vive con questo padre biologico lontano e impersonale un “rapporto edipico” sui generis. Il buon samaritano della banca del seme ha infatti acconsentito a rivelare la propria identità ai discendenti una volta che questi avessero compiuto la maggiore età. Coesistono così nel figlio pulsioni contrastanti: nel descrivere l’atto del padre-donatore sembra intessere una sottile reprimenda, ma poi ammette di volerlo incontrare, sia pur “con gli occhi chiusi”. Federigo Tozzi non avrebbe saputo dirlo meglio: questo Pietro Rosi dall’accento veronese mostra al pubblico tutta la fragilità di una generazione, sempre più numerosa, di giovani alla ricerca di sé, su un sentiero che pone in eterna dialettica biologia e amore.
Un viluppo, questo, che trova sfogo in due scelte registiche solo in apparenza contrastanti: da una parte, la brama fisica, la corporeità, la carnalità che trasudano dallo spettacolo, fino all’insistita rivendicazione dell’incesto con la propria “sorella di sperma”; dall’altra, l’eloquio scandito, monocorde e piatto: due scelte che hanno creato, fin dai tempi di “Made in Italy”, il marchio di fabbrica di Babilonia Teatri. E che in questa nuova prova risultano azzeccate nel loro rimando alla contraddizione clinica, asettica, di un bambino plasmato in laboratorio, tra gameti a distanza, ma per volontà fortemente carnali.
Allieta, sul finale, l’happy ending: a Natale la famiglia (geograficamente) allargata si riunirà a Roma, e finalmente il nostro Kafka potrà trovare una rasserenante risposta al problema di matematica che lo aveva tanto ossessionato. Sarà anche l’occasione per prendere una decisione importante: un giorno sarà “padre”. Trasmetterà a qualcun altro il proprio DNA, il proprio pedigree.
Sono state “tre serate speciali, per amateurs e per spettatori civili” gli altrettanti appuntamenti tenacemente voluti e “consumatisi” sul palco del Teatro India di Roma che ha generosamente ospitato la ventitreesima edizione della rassegna Garofano Verde – scenari di teatro omosessuale curata da Rodolfo di Giammarco. Una rassegna desiderata con caparbietà da Società per Attori, nonostante la mancanza di sostegni istituzionali, e appoggiata dal Teatro di Roma che ha messo a disposizione i suoi spazi. Il resto l’ha fatto la selezione dei testi a cui lo stesso curatore augura “un prosieguo di rappresentazioni ancora più ufficiali, più definite, più programmatiche”. Destino già vissuto da precedenti lavori che qui hanno visto la luce, per poi conquistare le platee più diverse, vivendo di vita propria.
L’edizione 2016 di Garofano Verde sceglie di schierare in apertura “Pedigree” di Babilonia Teatri con la scrittura e la lettura di Enrico Castellani e la cura di Valeria Raimondi. “Pedigree” esplora un mondo ancora poco conosciuto ma molto attuale dei figli di coppie omosessuali, in questo caso due compagne-madri, indagando la psicologia del giovane figlio. La lettura si snoda attraverso fitti giochi di parole fatti di ripetizioni quasi ossessive condite dalle canzoni di Elvis Presley (una fra tutte Can’t help falling in love che caratterizza un emozionante ballo madri-figlio). Il racconto letto da Castellani è quello di un ragazzo che descrive la sua vita “diversa” rispetto a quella dei coetanei, una vita che comprende l’assenza del padre donatore e i cinque fratelli di sperma sparsi per il mondo.
Lo stile è quello tipico di Babilonia Teatri: asciutto ma schietto, sincero ma poetico. Seppure in una forma appena abbozzata e ancora primordiale (il testo in realtà è un work in progress), il breve reading descrive chiaramente la situazione di chi, avendo due madri o due padri, si sente come un animale al quale viene chiesto il proprio pedigree. Problemi di identità e di coscienza generano nuove domande alle quali non tutti e non sempre sono in grado di dare delle risposte adeguate. E il Garofano Verde è una rassegna che proprio per questo andrebbe tutelata e maggiormente sostenuta perché, soprattutto in questi anni un po’ bui, getta la giusta luce su una tematica di estrema importanza.
Quattro polli per otto persone uguale mezzo pollo a testa. Un calcolo semplice, di quelli che anni di scuola ci hanno insegnato a fare a mente, e i conti ecco che quadrano alla perfezione, consegnando ad ognuno la parte che gli spetta. Ma le divisioni nella vita reale, chissà perché, non tornano mai, sembrano sempre restituire uno scarto, un’assenza a cui non è possibile rimediare. Altro che scienza esatta, nell’algebra dei sentimenti le incognite, come tarli cocciuti, trovano comunque uno spazio per la proliferazione.
Enrico Castellani, di Babilonia Teatri, legge Pedigree per il pubblico del Garofano Verde, ed è in questa mancanza, in questo residuo di fondo, che va ad insinuarsi con la prima versione del suo testo, ancora in progress, concepito appositamente per la rassegna romana di teatro omosessuale giunta, ormai, alla sua ventitreesima edizione.
In poltrona, luci soffuse, abiti comodi, iPad in mano, Castellani si fa scorrere fra le dita la storia di Simone e della sua famiglia allargata, con due madri di fatto, un padre donatore e cinque fratelli di sperma sparsi per il mondo ma riuniti insieme ogni Natale. Ed è proprio il genitore biologico, il presente/assente per antonomasia, il termine noto che non combacia nell’equazione imperfetta di questo paradigma, la parte che avanza e non si sa comporre, la metà di pollo che a Simone, fin dai problemi di matematica, è sempre stata indigesta. Perché è sulla sua pelle, nei tratti sconosciuti della sua fisionomia, nella coscienza di un’identità in fondo carente, che quel padre mai incontrato, eppur così presente, fa sentire la sua morsa di solitudine. In quest’abisso di incertezze, di desideri negati, di diritti e di consapevolezze che sono specchio del nostro tempo, Pedigree di Enrico Castellani mette piede con limpidezza, senza mai indugiare su sentimentalismi forzati, su rapide conclusioni, su ragionamenti fasulli. Scegliendo di raccontare con una disinvoltura che è cifra stilistica del linguaggio dei Babilonia, un linguaggio che si lascia attraversare, ed ascoltare, senza intoppi ma che non scivola via, rimane, nelle orecchie, sulla pelle, nel corpo, come una memoria anatomica che ferisce e colpisce per il peso di umanità che si porta dietro, nella poesia delle sue parole leggere.